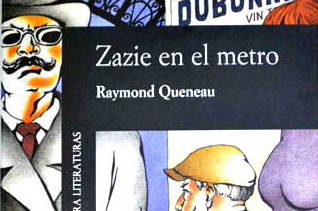Zazie nel metró,
la favola che scardina la letteratura
Queneau e il linguaggio, delirio e autoanalisi di un romanzo
«Siete buffi, voialtri» dice Zazie. «Non sapete mai
bene quel che pensate. Dev’essere faticoso. È per
questo che tanto spesso avete quell’aria seria?»
(Raymond Queneau, Zazie nel Metró)
Può un libro mettere in gioco sé stesso? Può una storia avere per oggetto la materia che la compone, tanto da trasformare i propri elementi costitutivi – personaggi, dialoghi, figure retoriche etc. – in un simbolo coerente che si autocritica? Doveva avere in mente questa sfida, Raymond Queneau, quando si accinse a scrivere Zazie nel Metro, la sua opera più celebre e la più apprezzata dal grande pubblico.
Uscito nel 1959 per Gallimard, in Francia, Zazie suscitò reazioni contrastanti: ci fu chi ne lodò la continua invenzione linguistica (una costante in Queneau, che in questo libro raggiunge vette di rara maestria) e chi ne contestò l’eccessivo ermetismo dei significati; chi ci vide una sfida degna della più approfondita esegesi, e chi lo ritenne un delirio incomprensibile, sottoscrivendo quanto sostenuto da Gabriel, uno dei personaggi principali del libro:
«Parigi è solo un sogno, Gabriel è solo un’ombra (incantevole), Zazie il sogno di un’ombra (o di un incubo) e tutta questa storia il sogno di un sogno, l’ombra di un’ombra, poco più di un delirio scritto a macchina da un romanziere idiota».
Ancora oggi, Zazie rappresenta una lettura difficile per il lettore sprovvisto di strumenti critici. O meglio: una lettura insidiosa; tanto più ingannevole in quanto, all’apparenza, facilmente percorribile. Le descrizioni ridotte all’osso, i dialoghi serrati, i botta e risposta spassosi e le situazioni-sketch ne fanno un libro intrigante, spiritoso, sulle cui righe l’occhio corre veloce e senza troppo affanno. Eppure, man mano che ci addentriamo nella vicenda, accompagnando la protagonista per le strade di una Parigi vittima dello sciopero ferroviario, il tessuto del racconto pare smagliarsi: forme ambigue affiorano, in trasparenza, dietro ogni episodio; i giochi di parole e le assurde discussioni sembrano alludere ad altro; Parigi è un simbolo; Zazie, è un simbolo: lo intuiamo, ma non sappiamo decifrarlo; e ben presto capiamo di essere caduti in trappola.
Sono gli anni ’50. Zazie è una bambina vivace, ribelle, testarda e maleducata. Da grande vuol fare l’astronauta, per rompere le balle ai marziani. La madre l’affida allo zio Gabriel, un colosso ambiguo (come ogni altro personaggio, del resto) nel quale si mescolano bontà ed eloquenza. Dopo solo un giorno, Zazie scappa, e Gabriel le si mette alle calcagna. È l’inizio di una serie d’incontri e di altrettanti testa a testa, durante i quali Zazie si confronterà con un poliziotto in borghese (che potrebbe essere anche un pedofilo in uniforme e chissà cos’altro) ma sfrutterà la circostanza per aggiudicarsi un paio di jeans. Si lancerà con lo zio alla scoperta di Parigi. Torchierà psicologicamente l’amico Charles con domande di carattere sessuale. Incontrerà un pappagallo monocorde, una vedova consolabile e altri bizzarri personaggi.
Tutto il libro è infarcito di conversazioni paradossali e diremo subito che il dialogo rappresenta, in Zazie, lo strumento privilegiato, nonché la spia messa lì dall’autore a suggerirci l’ambiguità del linguaggio. Vediamo un esempio. Gabriel e Zazie sono sul taxi dell’amico Charles. Ecco la conversazione in cui sono invischiati:
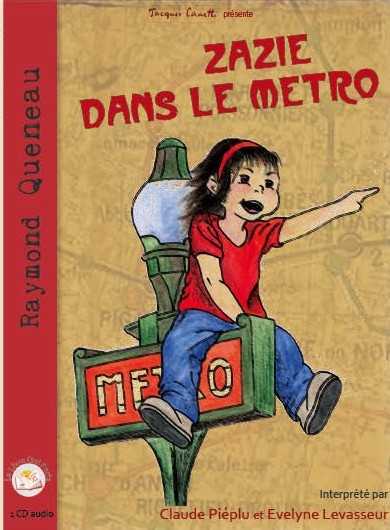 «Fra poco ci siamo» dice Gabriel conciliante. Ecco il tabaccaio dell’angolo.
«Fra poco ci siamo» dice Gabriel conciliante. Ecco il tabaccaio dell’angolo.
«Di quale angolo?» chiede Charles, ironicamente.
«Dell’angolo della strada mia, dove sto di casa» risponde Gabriel, con candore.
«Allora» dice Charles «non è quello».
«Come» dice Gabriel «vorresti pretendere che non sarebbe quello?»
«Ah no, eh» scoppia Zazie. «Non ricominciate».
«No, non è quello» risponde Charles a Gabriel.
«Però, è vero» dice Gabriel, mentre passano davanti al tabaccaio. «Quello là, mai messo piede».
«Dimmi, zio» chiede Zazie. «Quando dici boiate del genere, lo fai apposta o senza volere?»
«È per farti ridere, bambina mia» risponde Gabriel.
«Non prendertela» dice Charles a Zazie Non lo fa apposta».
«Bel fesso» dice Zazie.
«La verità» dice Charles «è che ora lo fa apposta e ora no».
«La verità!» esclama Gabriel (gesto). «Come se tu sapessi che cos’è. Come se qualcuno al mondo sapesse che cos’è…»
All’apparenza un banale bisticcio, rivela in realtà un meccanismo alla base dell’intero romanzo. Marchiate da uno continuo sviamento del discorso, continuamente tarlate dall’equivoco, le conversazioni tradiscono il ruolo della piccola peste Zazie: l’eroina (forse bisognerebbe definirla anti-eroina) è la voce di un linguaggio che vuole abbattere ogni ambivalenza, aggredendola con un’istanza spregiudicata, insistente e spietata, al fine di smascherarne l’ipocrisia e gli intenti reconditi, o anche solo la carenza di messa a fuoco. In altre parole, Zazie è la voce che mette a nudo la doppiezza della retorica, non si lascia incantare dal suo fascino e per questo ci appare tremendamente adulta. La ragazzina sembra conoscere i grandi meglio di loro stessi, li coglie in flagrante e li inchioda ogni volta che il discorso non bada al sodo, devia dalla realtà o si perde in rigagnoli allusivi.
ZAZIE: Perché si dicono certe cose e non altre?
CHARLES: Se non si dicesse quel che si deve dire non ci si farebbe capire.
ZAZIE: E lei, lei dice sempre quel che deve dire per farsi capire?
Sopratutto, Zazie non si lascia fregare dalla personalità. Come ha messo in luce Roland Barthes nell’imprescindibile saggio in appendice all’edizione Einaudi: «Per Queneau la Letteratura è una categoria di parola, ossia di esistenza, che concerne tutta l’umanità». Come a dire che la letteratura siamo noi, a prescindere dagli scrittori. Essa, ci suggerisce Queneau, parte da un oggetto – un’idea, un paesaggio, un’opinione, un’informazione – con l’intento di rappresentarcelo, o analizzarlo, e finisce per avvolgerlo di un secondo senso o fine. La personalità deforma l’oggetto del discorso fino a fagocitarlo. È qua che interviene Zazie, mettendo a nudo questa duplicità, ridicolizzandola. Zazie tira giù le mutande ai grandi che si fanno poeti altisonanti e per questo ci fa ridere. È un’arma nelle mani dell’autore, che la utilizza per mettere alla prova la materia prima del suo lavoro. Qui sta il grande paradosso che rende il libro di Queneau un capolavoro: Zazie – intesa come libro e come personaggio – è comunque letteratura. Ne deriva un meraviglioso cortocircuito, evidente soprattutto nel finale. La letteratura spiegata a sé stessa ci rivela un vuoto, provocando un’irresistibile effetto comico che allo stesso tempo ci impensierisce. Leggere Zazie restituisce una sensazione simile a quella di due specchi collocati uno di fronte all’altro. Ma anche la sensazione di vedervi riflessa la vacuità che connota la maggior parte delle nostre conversazioni. Spesso parliamo semplicemente per parlare, per riempire un vuoto, o per strappare consenso a prescindere dalla concretezza logica del discorso (si pensi alla politica). Anche le discussioni più infervorate si rivelano chiacchiericcio, se prive di risvolti pratici. Come ripete il pappagallo Laverdure:
«Chiacchieri, chiacchieri, non sai far altro».
Fosse solo un gioco di simboli sapientemente orchestrato, a Queneau si potrebbero fare le congratulazioni per l’ingegno. Ma i suoi meriti non si fermano qui. In Zazie c’è anche un’intelligente derisione di argomenti all’epoca considerati scabrosi (nel senso che se ne parlava poco) quali l’omosessualità e la pedofilia. Lo scrittore sembra dunque prendersi gioco di tutto in questo libro: della materia narrata, della letteratura, di sé medesimo in quanto romanziere, dei tabù della piccola borghesia francese, della sua lingua madre. Un libro denso, insomma. Spassoso ma impegnativo, costruito con una tecnica formidabile: nella scrittura corrono i fili di generi diversi, ogni volta parodiati, eppure sempre amalgamati. Gli esercizi di stile sono qua presenti, ma impliciti, mimetizzati e soggetti a una deformazione; sono funzionali e al contempo operano una specie di demolizione: per Roland Barthes, quella che contempliamo in Zazie «è come la bellezza delle rovine».
Acquisite alcune chiavi interpretative, Zazie ci appare molto meno delirante di quanto il suo autore non voglia far credere. Eppure, un’ultima legittima domanda ci sfiora: non è che tutto questo intellettualismo, tutta questa tessitura simbolica, rischiano di compromettere il piacere della lettura? Lo diremo sottovoce, qua, e con una certa cautela: forse un po’ sì. Zazie resta un’opera fondamentale; ma alla fine del gioco, svelati i trucchi e gli inganni, dopo lo stupore e la giusta ammirazione, sulla punta della lingua permane un che di asettico, una certa freddezza dovuta a tanto calcolo. Come tutti gli scrittori dotati di una tecnica mostruosa, Queneau corre questo rischio. C’è un passaggio, nel Giovane Holden di Salinger, nel quale Caufield si esprime a proposito di un bravissimo pianista: «Non c’è dubbio che mi piace sentirlo suonare» dice Holden «ma certe volte mi viene la voglia di buttargli quel maledetto piano a gambe all’aria».
- “Uliano Martini. Una storia di arte e umanità” - 9 Aprile 2025
- Lettura pubblica del Manifesto di Ventotene - 9 Aprile 2025
- Mds presenta “Vita fronte retro” - 9 Aprile 2025